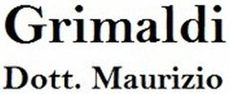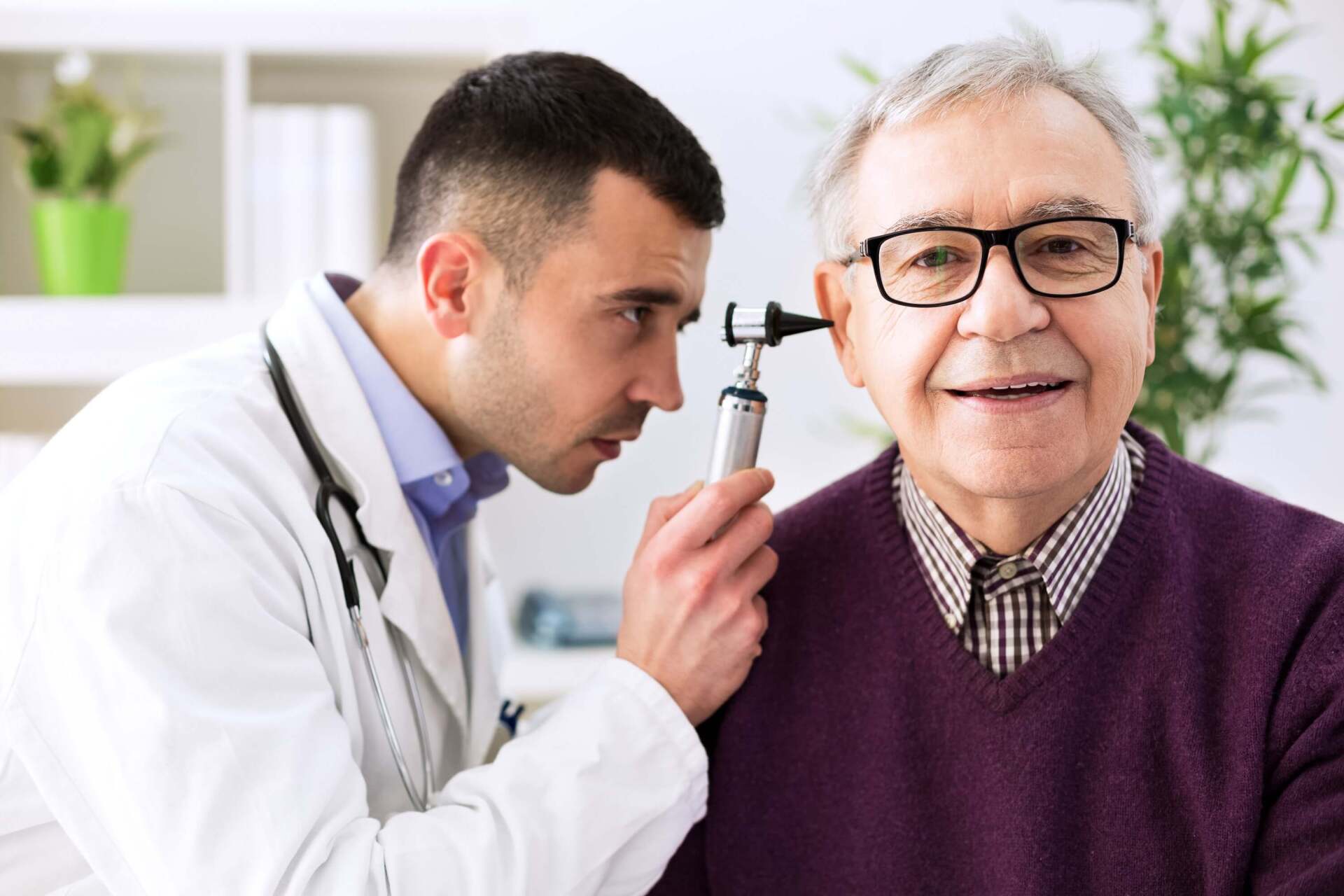Diagnosi e cura delle malattie con visite a orecchio, gola e naso presso l'otorino a Bologna





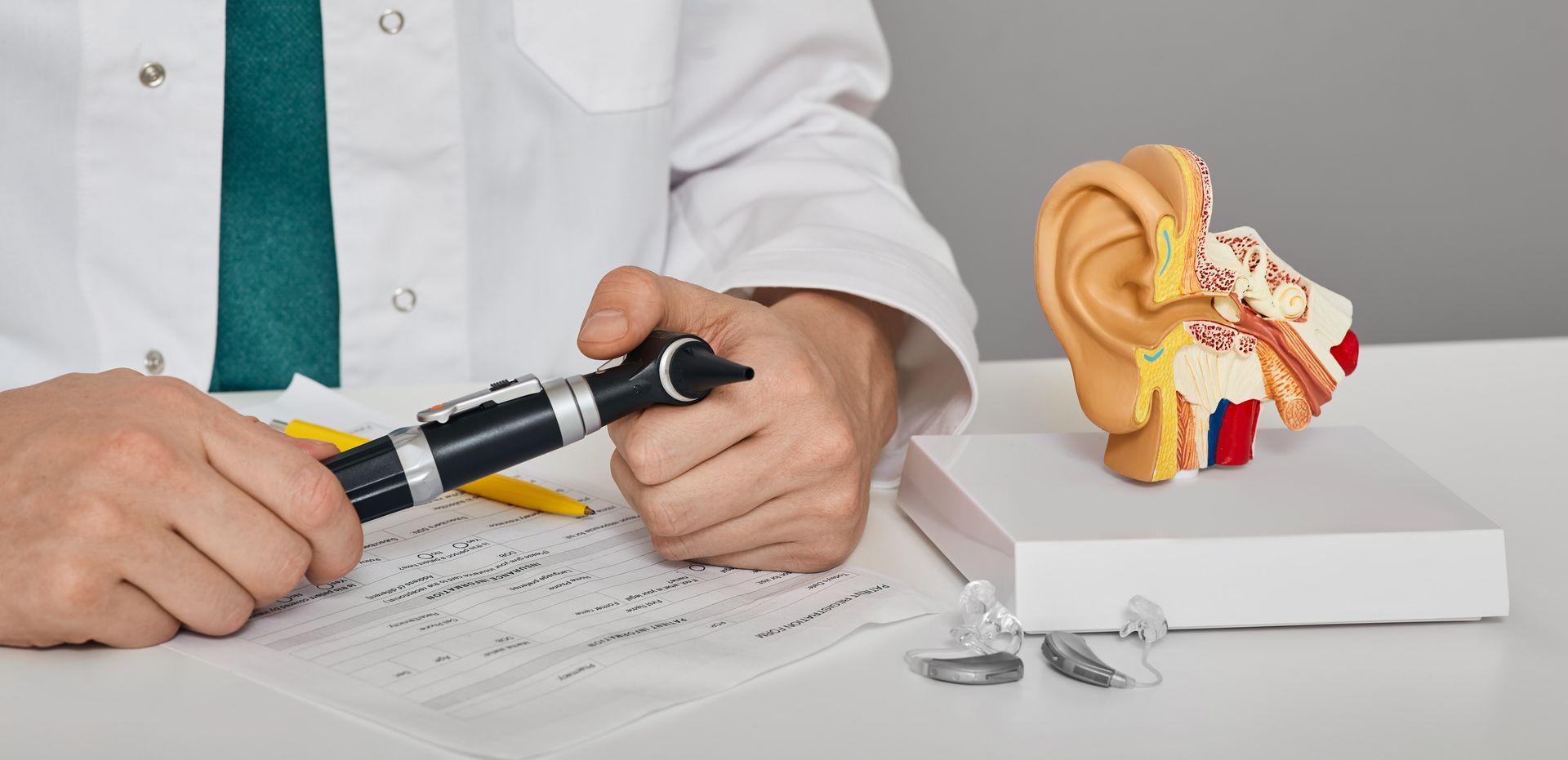




NEURINOMA DEL NERVO ACUSTICO
INTRODUZIONE
Schwannoma vestibolare; tumore a lenta crescita benigno, solido o cistico ad origine dalle cellule di Schwann del nervo vestibolare che insieme al nervo cocleare costituisce l’VIII nervo cranico o nervo acustico. La localizzazione di questi tumori è preferibilmente entro il condotto uditivo interno e successivamente il tumore si accresce verso l’angolo pontocerebellare. Comunque, sedi possibili sono la sede intrameatale, intra-extrameatale o primariamente extrameatale nell’angolo pontocerebellare (APC). Questi tumori rappresentano circa l’80% dei tumori dell’APC e l’8 % di tutti i tumori intracranici con una incidenza di 1 caso l’anno circa ogni 100000 abitanti.
TAPPO DI CERUME AURICOLARE
Il cerume è prodotto dalle ghiandole apocrine dei follicoli piliferi della cute del condotto uditivo esterno nella porzione cartilaginea e ricopre come un film l’epidermide, mantenendo l’acidità nell’ambiente con una azione batteriostatica; è una secrezione di aspetto ceroso giallo-nerastra prodotta dalle ghiandole ceruminose e sebacee.
Il cerume ha delle funzioni protettive sul condotto uditivo esterno impedendo l’ingresso di materiale estraneo (polvere, insetti, batteri, funghi, ecc) e lubrificando il canale uditivo in modo da evitare l’essiccamento della cute mantenendo una giusta umidità. Inoltre, presenta una attività antimicrobica battericida e antifungina grazie alla presenza di lisozima, particolarmente efficace contro alcuni batteri tipo Stafilococco aureo, Haemofilus influenzae ed Escherichia coli e anche contro alcuni funghi come Candida ed Aspergillo. L’azione antifungina sembra anche dovuta alla presenza nel cerume di acidi grassi saturi e al suo pH acido. Quando il cerume si accumula in eccessive quantità all’interno del canale uditivo può ostruirlo formando una concrezione solida, detta tappo di cerume, che determina un ovattamento auricolare con perdita uditiva più o meno marcata, associata a volte a senso di irritazione e dolore. Il tappo di cerume, che in molti pazienti si forma periodicamente a distanza di tempo variabile da mesi ad anni, può essere la conseguenza di una produzione abbondante del secreto ceruminoso o anche di un alterato movimento di espulsione verso l’esterno, a volte favorito da alterazione anatomiche del condotto come esostosi multiple o voluminose e presenza abbondante di peli. Il cerume è una sostanza igroscopica e quindi assorbe l’acqua per cui, a contatto con essa, tende ad espandersi e gonfiandosi può occludere completamente il canale uditivo.
Alcune condizioni favorenti l’accumulo di cerume sono rappresentate dalla dermatite seborroica, dall’età infantile in cui le ghiandole ceruminose sono iperattive, da stenosi infiammatoria del canale uditivo esterno, dall’uso di protesi acustiche che ostacolano la fisiologica dispersione e fuoriuscita del cerume, dall’uso abituale del cotton-fioc che tende a compattare il cerume spingendolo sul fondo del condotto uditivo favorendone l’accumulo.
EPISTASSI
“Epistassi” è un termine medico per indicare la perdita di sangue dal naso ad origine dai vasi sanguigni che irrorano le pareti delle cavità nasali e di solito interessa una sola narice. La maggior parte delle persone sperimentano almeno un episodio di epistassi nel corso della vita, il più delle volte con evoluzione clinica non grave, e solo in circa il 10% dei casi sono necessarie cure mediche.
Sono maggiormente inclini a questa patologia le seguenti categorie di persone:
- Bambini tra i due e i 10 anni: l'aria secca, i frequenti raffreddori, le riniti allergiche e l'infilarsi le dita e gli oggetti nel naso rendono i bambini più esposti al rischio di sanguinamenti nasali.
- Adulti tra i 45 e 80 anni e oltre: il sangue può richiedere più tempo per coagularsi negli anziani. Questi pazienti hanno anche maggiori probabilità di avere l’ipertensione arteriosa , l’aterosclerosi (indurimento delle pareti arteriose) e disturbi della coagulazione.
- Donne incinte: i vasi sanguigni endonasali si espandono durante la gravidanza , il che esercita una maggiore pressione sulle pareti dei delicati vasi sanguigni.
- Persone che assumono farmaci per fluidificare il sangue: questi farmaci includono antiaggreganti ( ad es. cardioaspirina, clopidogrel ) e farmaci anticoagulanti ( ad es., Coumadin, Eliquis, Lixiana, Xarelto, Pradaxa).
Alla vascolarizzazione arteriosa del setto nasale concorrono diversi rami derivanti sia dalla carotide esterna che dalla carotide interna. Tali rami sanguigni terminali anastomizzandosi fra loro creano una ricca rete vascolare a livello della parte anteroinferiore del setto nasale denominata “ locus Valsalvae”. Le emorragie che originano in questa zona si definiscono epistassi anteriori.
A provenienza dalla carotide esterna sono i rami terminali mediali dell’arteria sfenopalatina (ramo terminale della mascellare interna), l’arteria palatina maggiore e l’arteria del sottosetto. Dalla carotide interna convergono in tale area i rami mediali delle arterie etmoidali anteriore e posteriore (rami dell’arteria oftalmica).
Nella parte posteriore delle cavità nasali esistono altre zone soggette ad emorragie, definite epistassi posteriori. Una zona è situata nella parte posteriore del vomere, nel punto di anastomosi tra i rami mediali dell’arteria sfenopalatina e quelli della palatina maggiore; altra zona , chiamata di Woodruff, è sulla parete laterale delle fosse nasali, nel terzo posteriore del meato inferiore, con rami provenienti soprattutto dal ramo laterale dell’arteria sfenopalatina.
In base al sito di origine dell’emorragia si distinguono quindi due tipi di epistassi : anteriore e posteriore.
Epistassi anteriore: è la più frequente , circa il 90% dei casi, di solito meno grave e meglio gestibile dal punto di vista clinico, comune nei bambini; origina dalla parte anteriore del setto nasale , di solito dal plesso vascolare del locus Valsalvae.
Epistassi posteriore: origina solitamente dal plesso vascolare sfenopalatino nella regione posteriore della cavità nasale. Può provocare forti emorragie con scolo ematico lungo la parete posteriore della gola ed è più comune negli adulti.
Comunque l’epistassi riconosce delle cause locali oppure generali.
Cause generali : ipertensione arteriosa di varia natura, cardiopatie congenite o acquisite, diabete, insufficienza epatica o cirrosi, uso di anticoagulanti, malattie infettive virali e batteriche (influenza, scarlattina, morbillo, polmonite, febbre reumatica, ecc.), malattie renali con ipertensione ed iperazotemia, deficienze vitaminiche ( vitamina K, C, ecc), malattie ematologiche (anemia aplastica, policitemia di Vaquez, agranulocitosi, leucemie, linfomi, emofilia, fibrinopenia, trombocitopenia, porpora di Schoenlein-Henoch, malattia di Rendu-Osler, ecc.), barotraumi (aviatori, pescatori subacquei, etc.)
Cause locali: traumi (accidentali, chirurgici o fratture), piccoli traumatismi locali ( soffiarsi il naso molto forte, mettersi le dita nel naso, cambiamenti dell’umidità e della temperatura con naso secco e screpolato, corpo estraneo endonasale, varici del setto nasale, polipo sanguinante del setto, neoplasie naso-sinusali, ulcera trofica del setto, riniti acute infettive, vasomotorie o allergiche, rinopatie granulomatose, eccessiva esposizione ai raggi solari, tumori del rinofaringe (fibroangioma giovanile, neoplasie maligne)
Compila il form per richiedere
un appuntamento con il dott. Maurizio Grimaldi - otorinolaringoiatra a Bologna